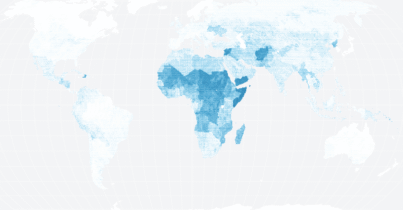A dieci anni dalla crisi, il lavoro è il punto di incrocio fra la perdita di competitività profonda del nostro tessuto economico – nell’intersecarsi fra i laureati e gli occupati in professioni intellettuali e tecniche fra i 25 e i 49 anni, tanto strategico per compiere un salto di qualità tecno-manifatturiero, l’Italia è fra le peggiori in Europa con il 23% dei primi e il 35% dei secondi – e l’incapacità atavica del nostro sistema istituzionale di prendere una precisa direzione di marcia. Non si è deciso di superare il dualismo del mercato del lavoro, diviso tra insider protetti e outsider privi di tutele, con la scelta compiuta nel Jobs act di non modificare l’Articolo 18 per chi aveva già un lavoro a tempo indeterminato. Il risultato è un sistema senza una precisa fisionomia, che diventa un campo di battaglia permanente per gli scontri politici e gli agguati culturali. Perché, intorno al lavoro italiano, mille tasselli si compongono e ricompongo di continuo, in un mosaico mutevole e ipercinetico. Secondo l’Istat, il tasso di disoccupazione è salito dal 6,7% del 2008 alla punta del 13,5% toccata nel primo trimestre del 2014, per poi assestarsi all’11,6% del terzo trimestre del 2016. I numeri puri, rispetto ai numeri percentuali, possono avere una maggiore forza di rappresentazione. I nostri connazionali disoccupati erano nel 2008 1,6 milioni, nel primo trimestre del 2014 sono più che raddoppiati arrivando a sfiorare i 3,5 milioni, nel 2016 sono tornati 3 milioni. Sono balzi weimariani o, per restare in Italia, da biennio rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile, che era pari al 21,2% nel 2008, ha avuto il picco del 46,2% nel primo trimestre del 2014, per poi “scendere” al 34,5% del terzo trimestre dell’anno scorso. Nel 2008 i ragazzi fra i 15 e i 24 anni senza un lavoro erano 388mila e, nei dieci anni che hanno piegato il Paese, a un certo punto – nel primo trimestre del 2014 – sono diventati 743mila, per poi calare nel terzo trimestre del 2016 a 543mila.