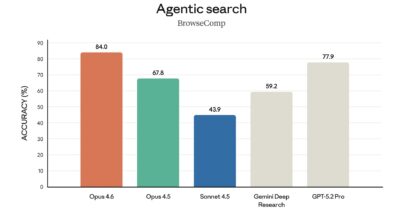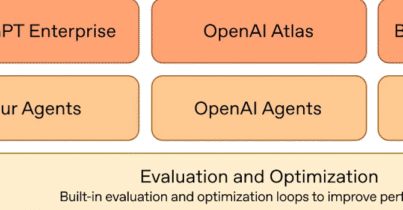Big Data è oggi un “meme”, una parola sulla bocca di tutti, un imperativo categorico per le imprese. Come siamo arrivati a questo punto? Sono ormai 25 anni che si parla di estrarre senso dai dati, scoprire conoscenze nascoste nelle grandi masse di dati generati da processi e transazioni mediati dalle tecnologie digitali. Già a cavallo fra gli anni 80 e 90, quando nacque l’idea di data mining, avevamo consapevolezza che nei dati che si accumulavano nei sistemi aziendali ci fossero giacimenti non sfruttati di conoscenze. Come il famoso pattern “birra e pannolini”, che emergeva dagli scontrini degli acquisti del fine settimana, a mettere in luce il segmento delle coppie di giovani neo-genitori che invitano gli amici a casa. Da allora il panorama digitale è cambiato molto, ma l’idea di fondo di quella che oggi chiamiamo Big Data Analytics è la stessa: usare in modo creativo sorgenti multiformi di dati per generare conoscenze utili e inaspettate. Per lasciare che le storie emergano dalle tracce digitali dei comportamenti umani. Sono le tracce ad essersi moltiplicate in varietà, pervasività e quantità. Inevitabilmente, le sfide per le imprese si sono dilatate ben oltre lo sfruttamento più intenso dei soli dati interni.
I numeri dei Big Data sono veramente impressionanti, a partire da quel trilione di euro di valore stimato per i dati delle nostre vite digitali, passando per i 44 trilioni di gigabyte di dati previsti per il 2020, arrivando fino ai 2,4 trilioni di Pc, tablet e telefonini venduti nel 2015. Quella dei Big Data è una vera e propria miniera, che se sfruttata con perizia può portare a notevoli vantaggi in molti ambiti diversi, dalla gestione degli aeroporti, agli sport fino alla sanità e alla grande distribuzione.
Tratto da Il Sole 24 ORE del 01/11/2015, pagine 12 e 13