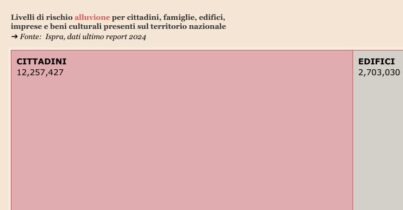In una fase di crescente protezionismo e “disamoramento” per la globalizzazione, le misure protezionistiche sono forse l’unica costante degli ultimi anni. Secondo Sace, solo nei Paesi che compongono il G20, le barriere elevate dal 2008 ai primi mesi del 2016 sono oltre 3.500. Quasi un quarto di queste impongono l’obbligo di avere almeno una certa percentuale di un prodotto o servizio realizzato nel Paese soprattutto per prodotti elettronici e veicoli. Da sole nel 2015 appena quattro di queste misure hanno formato il 60% di tutte le iniziative di distorsione del libero scambio.
Alle limitazioni tradizionali (local content, eccesso di certificazioni, etichettature e regole doganali) – quelle che sono cresciute di più in questi anni e che maggiormente contribuiscono al rallentamento – si aggiungono anche quelle indirette. Si arriva così a sfiorare le quasi 6.400 misure distorsive della libera concorrenza e del mercato.
Si tratta di scelte compiute soprattutto dai Paesi del G20: gli Stati Uniti, ad esempio, hanno introdotto dal 2009 una misura protezionistica ogni 4 giorni e sono il primo Paese per numero totale di limitazioni adottate (1.084). Seguono India (588) e Russia (460). Più a distanza, in 4° posizione, la Gran Bretagna; mentre la Cina è al nono posto.
Ma quali Paesi ne risentono di più? Come un boomerang, gli stessi che impongono queste limitazioni. Nell’ordina Cina, Stati Uniti, Germania, Italia e Francia, ovvero i principali esportatori.
I dieci settori più colpiti dal protezionismo rappresentano quasi il 41% del commercio mondiale: metalli di base, automotive e trasporti, prodotti agricoli, macchinari per usi speciali e chimica di base. Settori in cui l’Italia esporta non poco. Dall’inizio della crisi al 2016 la crescita degli scambi (+2,9%) è stata inferiore alla metà di quella registrata nel periodo 2000-2007 (+7,3%).