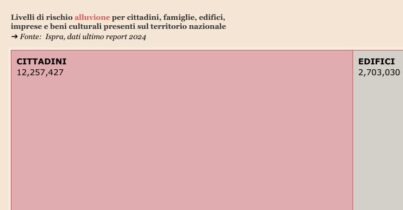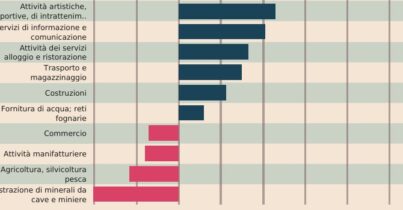Nonostante gli annunci di Trump – che minaccia un nuovo periodo di protezionismo – facciano paura, in realtà gli Stati Uniti hanno avviato già da tempo un processo di chiusura del proprio mercato alla penetrazione degli altri Paesi. Le barriere al libero scambio non sono fatte solo di dazi che rincarano il prezzo delle merci, ma anche di ostacoli più burocratici che vanno sotto il nome di “barriere non tariffarie” al commercio. Queste possono essere per l’impresa economicamente molto onerose, alla pari di un dazio.
Ma quanto incidono sulle transazioni commerciali delle imprese europee che esportano negli Stati Uniti? Il 44%, cioè pesano più o meno su un’operazione ogni due. In questo caso Usa e Cina si equivalgono: nel caso di Pechino le misure anti tariffarie incidono per il 48%. I veri libero scambisti sono altri: Giappone – dove le transazioni delle imprese europee che incampano degli ostacoli burocratici sono solo il 26% – il Canada e l’Australia (30%), Singapore (27%). Dall’altra parte gli Stati Uniti si rivelano alla pari con Paesi come la Tunisia, l’Ecuador e il Messico.
Secondo lo studio condotto dalla Commissione europea e dall’International Trade Centre, la media delle aziende europee che nel 2015 e 2016 è incappata in almeno un ostacolo tariffario è del 36%. Negli ultimi otto anni gli Stati Uniti sono stati il Paese al mondo ad aver elevato il numero più alto di barriere commerciali. Dal 2008 ai primi mesi del 2016 Washington ha alzato ben 1.084 muri contro il libero commercio. Una distanza siderale dall’India, che pure si è guadagnata il secondo posto nella classifica, fermandosi però a 588 barriere.
L’America quindi non si scopre protagonista con Trump. L’anno scorso infatti, nonostante le barriere incidessero negativamente sul 44% delle commesse italiane, l’export made in Italy verso gli Usa ha messo a segno una crescita del 10,5%. E per quest’anno si prospetta comunque un aumento del 7,8%.