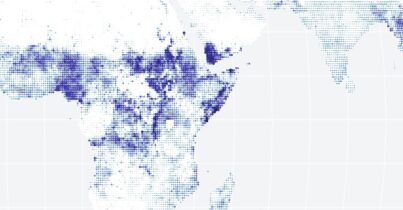Negli sport professionistici, specialmente per quelli mediaticamente più seguiti, la disponibilità economica e la volontà di investire da parte dei proprietari risulta essere spesso un fattore determinante per stabilire la natura dei vari campionati.
Negli Stati Uniti c’è una concezione molto più democratica nell’approccio agli investimenti rispetto alla concezione più oligarchica presente nel resto del Mondo ed i risultati in termini di distribuzione del successo sono analogamente contrapposti.
Nei campionati europei ad esempio, ed in particolare nel calcio, il blasone di una squadra è sempre stato legato alla potenza economica del club e viceversa. Così, per ogni competizione, esistono storicamente cinque o sei squadre di vertice che ciclicamente si alternano nelle vittorie.
Senza nessun tipo di limiti al budget, si innesca un inevitabile circolo vizioso caratterizzato da top-club che, a fronte di grosse disponibilità economiche, possono concedersi sia di stipendiare atleti di primissimo livello, sia di acquistarli da altre società minori che, pur avendoli fatti crescere tecnicamente, a cospetto di certe cifre, non possono permettersi di trattenerli.
Non deve quindi stupire se in Serie A, Premier League e Liga, negli ultimi 25 anni, si siano alternate alla vittoria dei campionati rispettivamente 5, 6 e 5 squadre.
Negli Stati Uniti invece, il sistema economico sportivo funziona sulla base di tre principi:
- i trasferimenti degli atleti tra le squadre avvengono solo attraverso scambi (di pari valore), svincolandosi dalla necessità di pagare “il cartellino”
- esiste il concetto di salary cap come limite (più o meno flessibile) di spesa durante una stagione, comune a tutte le società
- i giovani prospetti vengono distribuiti nelle leghe attraverso un draft annuale durante il quale le squadre di bassa classifica scelgono per prime
La NBA è un esempio perfetto di come il modello americano riesca a normalizzare le differenze di “classe” che esistono in altre realtà sportive andando a democraticizzare le possibilità di successo, senza che queste siano viziate dalle diverse disponibilità economiche dei proprietari, peraltro tutti sempre multimilionari.
Prendendo in esame gli ultimi 33 anni di campionato, iconicamente a partire dall’arrivo di Michael Jordan nella stagione 1984/85, delle 30 squadre partecipanti (anche se sono 30 solo dal 2004), ben 19 sono arrivate almeno una volta in finale per potersi giocarsi il titolo di campione.
Ampliando il concetto di successo non solo alla vittoria del campionato, ma ragionando in termini di percentuali di vittorie nell’arco delle singole stagioni, la normalizzazione dei valori appare molto più evidente: si passa dal 39,2% di media vittorie negli anni da parte dei sempre giovani Minnesota Timberwolves al 63,9% dei San Antonio Spurs, squadra che negli anni è sempre stata sinonimo di programma vincente (5 titoli in 6 finali tra il 1999 e il 2014).
Una differenza distribuita nel tempo di soli 24 punti percentuali tra gli estremi opposti è un risultato storicamente non osservabile in contesti controllati da una disparità economica tipica delle competizioni extra americane.
Nella NBA invece è assolutamente nella norma come si può anche verificare dall’alternanza cromatica della maggior parte delle squadre nel corso degli anni (gradiente da rosso a blu a seconda del bilancio stagionale).
Ci sono realtà affermate come i Los Angeles Lakers che, nel periodo esaminato, hanno disputato 12 finali (vincendone 8) distribuite su tre cicli temporali (anni 80′ dello Showtime con Magic Johnson, inizio millennio con la coppia Shaq-Kobe e Kobe-post O’Neal), alternate da stagioni mediocri, se non inaccettabili secondo la tradizione gialloviola, come le ultime quattro, mai chiuse con un bilancio superiore al 33%.
Seppur meno blasonati dei già citati San Antonio Spurs, un esempio particolarmente efficace di sistema vincente è quello proposto dagli Utah Jazz che, seppur perdendo entrambe le finali raggiunte negli anni 90′, hanno saputo costruire attorno alla coppia Stockton-Malone per un ventennio, riuscendo poi a ripartire in maniera decorosa anche dopo il loro ritiro.
L’aspetto più incredibile del caso Jazz (58,6% media vittorie nel periodo), terzi dopo Spurs e Lakers, è la collocazione geografica della franchigia.
Trasferitisi a Salt Lake City nel 1979, i Jazz, pur dovendo fare i conti con un mercato insignificante dal punto di vista mediatico e decisamente poco “glamour” per attirare free agent, sono stati in grado di seguire un percorso quasi sempre vincente che vanta 28 stagioni chiuse con bilancio positivo sulle 33 prese in esame.
All’estremo opposto invece, il caso dei New York Knicks è forse la fotografia più rappresentativa del fatto che “anche i ricchi piangono”.
Anche a fronte di un brillante decennio durante gli anni 90′, corredato da due apparizioni in finale (entrambe perse), non sono bastati nè il fascino della Grande Mela, nè l’ovvia esposizione mediatica e nemmeno l’innegabile appeal del marketing a far sì che una delle storiche franchigie della NBA potesse fare meglio di un eloquente 47,8% medio di vittorie; appena un soffio sopra il risultato dei Denver Nuggets (47,3%), non di certo una potenza nell’universo NBA.
Molto spesso infatti, squadre come i Knicks si trovano nella temuta situazione di aver a disposizione denaro da spendere (in relazione al salary cap) ma senza nessuna superstar che sia disposta ad accettarlo, preferendo accasarsi altrove con lo stesso stipendio o, come sta accadendo recentemente, anche a cifre minori, pur di giocare in un ambiente competitivo o quantomeno promettente per il futuro.
Negli ultimi anni infatti, i giocatori veterani diventati free agent stanno facendo carte false per trovare un contratto al minimo salariale con i Golden State Warriors, vincitori di due degli ultimi tre titoli ed in grado di far registrare in queste stagioni i valori record per quanto riguarda le vittorie stagionali su tre anni consecutivi (81,7% nel 2014/15, 89% nel 2015/16 ed ancora 81,7% nel 2016/17).
Non c’è poi da stupirsi se nel corso del periodo analizzato, nonostante tutto, il bilancio medio dei Warriors reciti un misero 45,7%, ben lontano da qualsivoglia forma di blasone pluriennale in stile Boston Celtics o Los Angeles Lakers.
Michael Jordan diceva che “con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”.
Probabilmente è stato e sarà sempre uno dei pochi aspetti romantici della cultura americana in cui i soldi, forse perché ce li hanno in tanti, non fanno necessariamente la felicità.