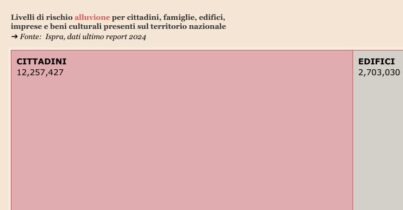Con l’inizio del campionato Nba, a breve cominceranno ad arrivare i primi verdetti, spesso impietosi, su quanto bene (o male) possano avere lavorato i general manager durante la off season. L’estate è infatti il periodo in cui attraverso le firme dei free agent e gli scambi di giocatori, le squadre cercano di assemblare il miglior roster possibile in funzione di due fattori fondamentali: ambizioni future e salary cap, ossia il limite salariale (teorico) imposto per equilibrare la competitività tra le squadre. Come le altre tre leghe principali degli Stati Uniti (NFL, MLB e NHL), seppur con alcune varianti, anche la NBA prevede un modello votato a normalizzare le possibilità di successo stabilendo delle direttive alle quali ogni squadra deve attenersi in relazione ai salari dei propri atleti. Per la pallacanestro a stelle e strisce sono due le cifre che fanno da sparti acque: il salary cap appunto e la luxury tax.
Questo sistema ruota attorno ad un “soft” cap, così definito se confrontato a quello di altri campionati (come la NFL) con molte più restrizioni, caratterizzato da alcune eccezioni (excpetion) grazie alle quali, in determinate circostanze, è consentito sforare il limite prestabilito. Pur prevedendo eventuali casi particolari in cui si può aggirare il tetto salariale (fissato a 99 milioni di dollari per il 2017/18), la luxury tax (119 milioni per la stagione in corso) è il valore oltre il quale le franchigie devono pagare una tassa calcolata in base all’ammontare dell’esubero degli stipendi e alla recidività del superamento dei limiti nel corso degli anni. Se è vero che gli obiettivi futuri determinano necessariamente l’approccio col quale ci si relaziona al salary cap, molto spesso è forse più vero il viceversa.
Capita infatti che per scelte fatte in passato e rivelatesi poi infelici, ci siano molte squadre che devono fare i conti con una situazione salariale complicata al punto tale da imbrigliare le ambizioni dei team che, salvo clamorosi sconvolgimenti, come ad esempio la cessione di una superstar e del relativo “contrattone”, possono trascorrere anche un paio di stagioni in un limbo di mediocrità.
Nel grafico è illustrata la situazione salariale delle 30 squadre NBA fino alla stagione 2019/20 ed è rappresentata da una terna di marker circolari che indica quanto ogni team si è già impegnato a pagare per la stagione in corso (blu), la prossima (arancio) e per quella seguente (rosso).
In aggiunta cliccando sui marker di un team, appare il dettaglio salariale dei singoli giocatori spacchettato per i tre anni presi in esame.
Visto il recente trend caratterizzato dalla costituzione di cosiddetti “super team”, non deve stupire se per la stagione 2017/18, nelle prime due posizioni compaiono le due squadre che hanno disputato le ultime tre finali, Golden State e Cleveland, appaiate con 137 milioni di dollari.
C’è infatti una innegabile tendenza delle squadre di vertice nel volere investire tutto, anche più del previsto, per provare a vincere subito, o quantomeno con la speranza di avvicinarsi il più possibile alle Finals.
In un certo senso, i Warriors e i Cavs, seppure allineati in termini di numeri, rappresentano due realtà diametralmente opposte.
Da una parte, Golden State continua ad aggiungere tasselli sempre più preziosi (non ultimo Kevin Durant nella passata stagione) ad un nucleo principalmente costruito nel corso del tempo attraverso le scelte del draft e riconfermato in toto a suon di estensioni contrattuali inequivocabilmente onerose (Curry, Thompson e Green su tutti).
Dal canto suo invece, Cleveland, specialmente quest’anno, continua ad aggiungere giocatori attorno a LeBron James che funge da calamita per attirare free agent o ambite merci di scambio con altre squadre orientate ad un processo di ricostruzione (Thomas, Wade, Rose, Green, ecc…)
In entrambi i casi comunque, se paragonati con altre realtà, Warriors e Cavs, come anche i Thunder del nuovo trio Westbrook-Anthony-George, risultano molto più propense al “vincere subito” come dimostra il gap tra la somma dei salari per la stagione in corso (sempre sopra i 134 milioni) e quella 2019/20 in cui gli stipendi già programmati oscillano tra gli 80 e i 90 milioni di dollari.
Maggiore è il divario tra queste cifre, più è probabile che si tratti di squadre con l’obiettivo di essere competitive nell’immediato, senza quindi impegnarsi con contratti a lunga scadenza, per poi decidere sui futuri investimenti alla luce dei risultati che potranno arrivare.
Rimanendo nella zona over luxury tax, i casi più eclatanti sono quelli dei Clippers che recentemente hanno esteso Griffin al massimo salariale, oltre ad aver firmato Danilo Gallinari, degli Spurs giunti ad un bivio tra il retaggio del recente passato e le nuove leve capeggiate da Leonard affiancato dal veterano Aldridge, e degli Utah Jazz che hanno deciso di vincolarsi seriamente solo a Gobert.
Per contro, ci sono anche altri scenari in cui squadre di medio-alto livello come Boston, Portland e Toronto, sposando una linea più giovane e/o più orientata alla programmazione futura, sempre rimanendo ben al di sopra del salary cap, nel corso dei tre anni presi in esame hanno un gap salariale tra le varie stagioni davvero contenuto.
Dando uno sguardo alle franchigie che, per varie ragioni, risultano al di sotto del tetto salariale, la situazione appare abbastanza limpida.
In assenza di vere superstar affermate, le attuali possibilità di competere per il titolo sono davvero esigue e di conseguenza, nella migliore delle ipotesi ci sono contratti da rookie che ci si augura di poter estendere in un roseo futuro oppure, nello scenario meno incoraggiante, la speranza è quella di liquidarsi il prima possibile di giocatori mediocri con contratti al di sopra dei valori espressi e con l’obiettivo di presentarsi alle prossime free agency pieni dei dollari risparmiati grazie ai contratti andati in scadenza.