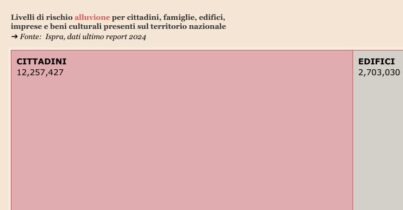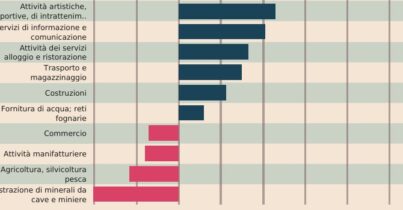Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2017 i pensionati sono in calo rispetto al 2016: un totale di circa 16 milioni di persone di cui 7,6 milioni uomini e 8,4 milioni donne, includendo sia le pensioni da lavoro che quelle assistenziali. Questo perché i nuovi pensionati sono meno numerosi dei pensionati cessati, quelli cioè che nello stesso periodo hanno smesso di percepire trattamenti pensionistici.
Il gap di genere risulta forte e svantaggioso per tutti, con buona pace di chi ancora sostiene che il modello tradizionale di famiglia dove l’uomo lavora e la donna si occupa della famiglia sia il solido pilastro economico del nostro paese. La donna che non era autonoma ieri, non lo è neanche oggi, ed è un costo per tutti e per tutte. Le pensionate che ricevono integrazioni al minimo sono 2,5 milioni, l’82,1% del totale dei destinatari di tali integrazioni. l’INPS riconosce infatti a chi ha una pensione al di sotto del cosiddetto minimo vitale, pari a 507,42 euro mensili, un integrazione di tale pensione fino a quest’importo. Dal 2019, in previsione del reddito di cittadinanza, l’ammontare minimo è pari a 780 euro al mese.
All’integrazione al minimo si aggiunge la possibilità di maggiorazione sociale per i redditi molto bassi, che evidentemente è fortemente sbilanciata a favore delle donne: sono 613mila le anziane che ne hanno diritto, il 74,5% di coloro che beneficiano di questi trasferimenti. Per il 2017 l’importo è di 638,33 euro mensili, pari ai 8.298,29 euro annui.
Nel complesso tra le pensionate il livello di reddito netto pensionistico (1.040 euro mensili) è pari a circa tre quarti di quello maschile, con marcate differenze rispetto alla tipologia di prestazione: l’ammontare delle pensioni nette da lavoro raggiunge appena il 60,5% di quello stimato tra gli uomini. In sintesi è molto maggiore il divario di reddito pensionistico da lavoro fra uomini e donne (a favore evidentemente dei primi), rispetto al “vantaggio” femminile in termini di reddito da pensioni di reversibilità.
C’è un altro aspetto di cui si parla sempre poco: la reale autonomia delle pensionate non vedove che pure avevano lavorato almeno un periodo della propria vita (magari in risposta a esigenze familiari che le avevano costrette a mettere da parte il lavoro per un lungo periodo), rispetto al reddito del marito. Se il reddito personale e del coniuge supera i 26.385,84 euro non si ha diritto ad alcuna integrazione. La pensionata, anche se ha lavorato almeno un po’, è comunque dipendente dal marito se egli ha un reddito abbastanza elevato per provvedere a lei.
A questo si aggiunge il fatto che il 18% delle donne anziane non riceve alcuna forma di pensione, contro il 3% degli uomini. In altri termini, in assenza di trattamenti pensionistici indiretti (prestazioni erogate in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato che aveva maturato un certo numero di contributi) circa una donna su quattro di 65-79 anni rimarrebbe priva di copertura pensionistica previdenziale e, in presenza dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente, subentrerebbe una copertura pensionistica assistenziale (pensioni sociali). Come visto, la maggior quota delle pensioni di vecchiaia spetta agli uomini, che beneficiano di importi medi per i quali si registrano più elevate differenze di genere (+60% a favore degli uomini nel 2017).
Il 2,7% dei pensionati, 441 mila individui, continuano tuttavia a lavorare (almeno regolarmente) dopo la pensione, anche se si registra un calo del 20% rispetto al 2011. Ma solo una su quattro è donna, e quasi tutti con basso titolo di studio, prevalentemente commercianti o persone impiegate nei servizi. Nel 2016 quasi la metà dei pensionati possiede al massimo la licenza elementare e appena uno su quattro è diplomato.
Il gap occupazionale tra uomini e donne – spiega Istat – è infine alla base delle differenze territoriali. Le pensioni di vecchiaia sono maggiormente diffuse tra i residenti del Nord mentre nel Mezzogiorno sono decisamente più elevate le quote di percettori di trattamenti assistenziali o di invalidità ordinarie.