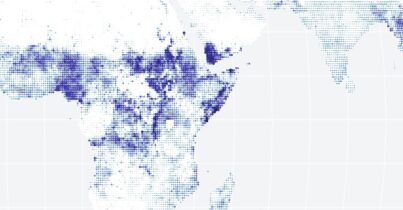In generale, come ricorda un articolo di Tito Boeri e Alessandro Caiumi su lavoce.info, la struttura produttiva dell’Italia è ancora particolarmente declinata verso l’industria, il che in diversi casi rende complicato passare al lavoro da remoto. Un quarto degli italiani è infatti occupato nella manifattura, con “un livello ancora limitato di digitalizzazione e robotizzazione”, per non parlare di “tre milioni e mezzo di operai nell’industria che oggi lavorano spesso l’uno a stretto contatto dell’altro”. Anche la dimensione media delle imprese non gioca a favore: tante aziende sono piccole, e questo di solito è associato a meno investimenti in tecnologie che consentono di restare produttivi a casa. Il risultato è che, secondo un rapporto dell’agenzia europea Eurofound, nel 2018 appena un italiano su cinque aveva lavorato a casa qualche volta nell’ultimo anno, contro nazioni che arrivano anche a uno ogni tre.
Altra cosa però è capire che effetto avrà il lavoro a casa sulla produttività dei lavoratori. Boeri e Caiuni citano per esempio “un’indagine curata da Astra Ricerche per Manageritalia su un campione di circa 1.400 iscritti all’associazione”, secondo cui “solo il 5 per cento dei rispondenti sostiene che il lavoro a distanza ha comportato un abbassamento della produttività per lavoratore”. Tuttavia “le cose cambiano da settore a settore: si va dall’11 per cento dei manager che riscontrano un impatto negativo del telelavoro nel settore dei media ed editoria al 2 per cento del settore It e telecomunicazioni. L’indagine Manageritalia poneva anche una domanda sulle aspettative dei manager riguardo all’adozione di questa modalità di lavoro anche dopo l’emergenza. Il 51 per cento dei rispondenti è convinto che potrebbe giovare al benessere dei lavoratori e alla produttività aziendale, a patto che vi sia una diversa organizzazione del lavoro. Anche in questo caso la percentuale varia notevolmente tra i diversi settori: si passa dal 61 per cento dei servizi assicurativi, bancari e finanziari al 32 per cento di turismo e ospitalità”.
Alcuni studi mostrano poi che anche se il lavoro a casa non viene scelto ma “imposto”, esso non provoca per forza una riduzione della produttività, anzi. Possono esserci forse problemi nella produttività per ora lavorata, ma “questo non è un problema per l’azienda posto che il lavoro agile (a differenza del telelavoro) non è basato su orari rigidi di lavoro, bensì sull’assegnazione di compiti da svolgere in un dato arco di tempo”. Al contempo stare a casa spinge a una maggiore frammentazione del lavoro, che a quel punto viene intervallato da un maggior numero di attività familiari, e questo può forse creare difficoltà nelle attività in cui un certo numero di compiti devono essere completati in rapida successione, a differenza di quando possono esserci lunghe pause fra essi.
Si tratta comunque di difficoltà secondarie. Secondo un paper di Marta Angelici e Paola Profeta (Bocconi), esiste evidenza che “la flessibilità dello smart working aumenta la produttività dei lavoratori e il bilanciamento vita-lavoro”, con effetti particolarmente significativi per le donne. Le autrici si riferiscono, nello specifico, ad accordi fra dipendenti e datori di lavoro per far svolgere ai primi e alle prime porzioni definite del proprio lavoro al di fuori dello spazio di lavoro dell’azienda e in base a una propria organizzazione del tempo. Quest’uso della flessibilità nel tempo e nello spazio “crea una nuova organizzazione del lavoro basata sui risultati, invece che sulla presenza in azienda e sul lavoro in orari specifici”.
Che probabilmente sia così le studiose l’hanno intuito dividendo 310 persone impiegate in un’azienda in due gruppi, e facendone lavorare metà in modo tradizionale e metà attraverso forme di smart working, per poi misurarne produttività, benessere individuale e bilanciamento vita-lavoro. A parità di ore lavorate, è venuto fuori, chi faceva parte del secondo gruppo è stato più produttivo, oltre a risultare anche più soddisfatto.