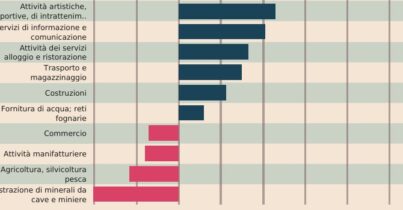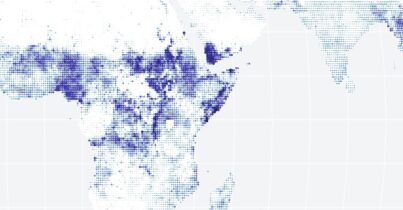Mettiamoci nei panni di un cittadino che si siede la sera sul divano per cercare di aggiornarsi sulle ultime novità riguardo al prossimo futuro di convivenza con il COVID19. Il caos informativo ora come ora è inevitabile, sia per un aspetto quantitativo che qualitativo.
Questo caos informativo lo crea la politica, ma lo creiamo soprattutto noi giornalisti quando scegliamo chi intervistare e che domande porre. Non stiamo parlando di malafede, ci mancherebbe, ma di scarsa esperienza nel fare informazione sul rischio e durante un’emergenza. Ci sono corsi di formazione sulla comunicazione in queste circostanze; ci sono linee guida internazionali (per esempio quelle OMS del 2018), progetti di ricerca di alto profilo (per esempio conoscete ASSET ?), tanta letteratura. Manca però la fase “traslazionale”, che porta tutta questa conoscenza nei percorsi di formazione e nei corsi di aggiornamento di chi poi si trova davvero a fare informazione in trincea “ai tempi del coronavirus”.
Non tutti gli esperti sono uguali. Ci sono i virologi, gli epidemiologi – e già questa distinzione basterebbe per ricalibrare meglio a chi chiediamo che cosa – ci sono i clinici, ci sono i data scientists, i biostatistici; ci sono i politici, gli economisti e ci sono i giornalisti specializzati. E soprattutto ci sono gli “scienziati” che lavorano dentro i tavoli tecnici, regionali e nazionali, e ci sono i docenti universitari e i ricercatori che valutano indipendentemente dall’esterno i dati.
Già fare le domande giuste alla persona che abbiamo davanti è una sfida, ma è cruciale, perché l’esperto giusto sa dirci se ha senso porci quella domanda oppure no a proposito di un dato, o di un fenomeno.
Un virologo sa come studiare un virus, sa come “interrogarlo” e che cosa ragionevolmente attendersi da lui a partire da determinate caratteristiche. Un virologo per esempio non lavora con i pazienti, anche se indossa un camice, non sta in reparto. Un virologo solitamente non studia l’epidemiologia di una malattia, non si occupa cioè di capire quali sono le correlazioni fra la sua diffusione e fattori ambientali, sociali, economici. Un epidemiologo lavora nell’ambito della Sanità Pubblica, ma non tutti gli esperti di sanità pubblica sono epidemiologi tout court.
L’aspetto quantitativo del caos è che non si riesce a seguire tutto quello che viene detto. Giungono spizzichi di post, briciole di tweet, incipit di articoli di giornale con lunghe interviste (e chi li legge tutti per intero?), parole tagliate dette in un servizio televisivo, frasi sentite a metà in una trasmissione ascoltata mentre si prepara la cena o si preparano i bambini per andare a letto. Dal punto di vista qualitativo invece, se all’inizio la situazione è parsa piuttosto polarizzata, e quindi relativamente semplice da inquadrare, con parte degli esperti che cercava di rassicurare, e alcuni che presagivano scenari più oscuri, mano a mano che le cose precipitano, la scala di grigi diventa più ricca, e le posizioni degli esperti finiscono per essere davvero tante.
Ma c’è un altro aspetto importante. Quando molti esperti si esprimono esercitando il proprio diritto di espressione (legittimo), non è detto che conoscano gli aspetti su cui si stanno confrontando gli esperti che in questi tavoli tecnici istituzionali ci lavorano. Non per ignoranza, certo, ma perché non è quasi mai chiaro come le istituzioni stanno lavorando dal punto di vista della pianificazione epidemiologica.
Non è così immediato inquadrare il ruolo del giornalista, quando viene invitato a sedersi sulla poltrona dell’esperto, magari accanto ad altri. Sono pochissimi in Italia coloro che stanno interpretando il proprio ruolo per quello che è, e cioè come “traduttore” di ciò che spiegano i vari esperti, in modo chiaro a chi ascolta, immaginando le domande di chi è a casa e magari incalzando chi dirige le danze con le domande più utili.
Dicevamo che in ogni caso il caos informativo lo innesca la politica, che dovrebbe mette insieme i saperi, e seguire la regola aurea oramai nella comunicazione istituzionale del rischio: mai sminuire il rischio, mai rassicurare a priori. Riconoscere il problema e incoraggiare. Le più recenti linee guida in materia sono quelle già citate dell’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicate nel 2018, dal titolo Communicating Risk in Public Health Emergencies A WHO Guideline for Emergency Risk Communication (ERC) policy and practice. Il documento – che analizza tutta la letteratura scientifica, anche grigia, sul tema – individuano alcuni pilastri per una buona comunicazione del rischio da parte di un’istituzione, fra cui costruire fiducia, coinvolgere le comunità, coordinarsi fra istituzioni, comunicare l’incertezza, avere chiari degli esempi da seguire.
Ma soprattutto le linee guida la pongono come una delle pietre d’inciampo nella comunicazione del rischio: incoraggiare il dialogo con i media, che non significa dare la possibilità ad alcuni di fare domande ad alta voce negli ultimi dieci minuti della conferenza stampa giornaliera della Protezione Civile, o farsi intervistare dai giornali di vari colori, ma significa per esempio media workshops per i giornalisti, quelli che si chiamano “media briefing”.
Ecco, forse quello che è mancato all’inizio alle istituzioni, generando un corto circuito informativo che ancora ci trasciniamo, è stata la mancanza di reale partecipazione nella comunicazione di questo nuvolone che si profilava all’orizzonte.